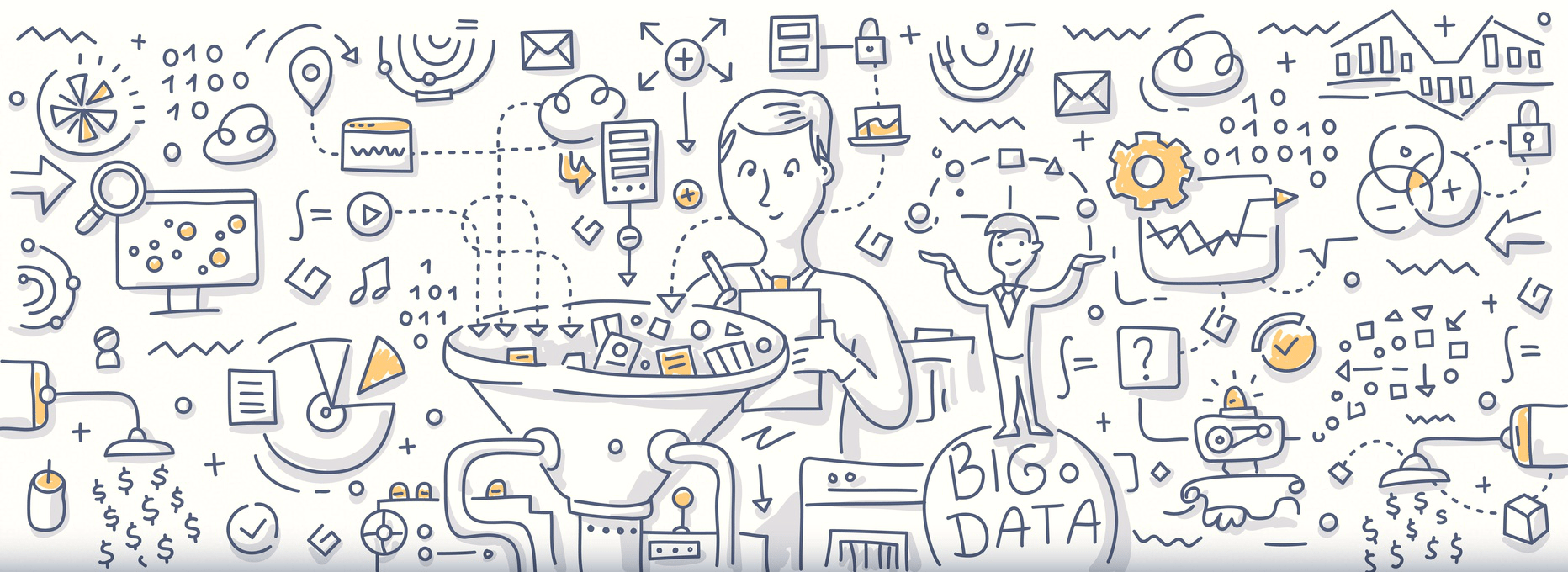La pandemia ci ha sempre più spostato in una dimensione tra l’online e l’offline, il digitale e l’analogico. Il XX secolo non è iniziato nel 1901, è iniziato con la Prima Guerra Mondiale: soltanto quest’ultima ha fatto da significativo divario tra un Ottocento molto lungo e un Novecento che è partito in ritardo. La pandemia ha fatto un po’ la stessa cosa con il XXI secolo. Un Novecento molto lungo che ha colorato anche il 2001 e gli anni successivi oggi è terminato e il XXI secolo è iniziato con l’esperienza dell’essere sempre un po’ connessi e digitali.
Questo è fondamentale, perché soltanto ora la vita “onlife” è diventata comune, distribuita ovunque, in ogni momento, tutti la capiscono, se ne parla come qualcosa di acquisito, dal lavoro alla scuola, dalla formazione all’intrattenimento, dai servizi alla sicurezza. In questo contesto, tra le tante questioni in campo, c’è anche una crisi della democrazia, che è una crisi di maturazione.
Per buona parte della modernità è stata raccontata una storia sbagliata, cioè che la democrazia rappresentativa non fosse in realtà la soluzione ma un ripiego. Una volta risolto questo errore, poi la comprensione del Terzo settore sarà davvero interessante anche da un punto di vista filosofico.
La democrazia rappresentativa non è alla base del problema: la nostra crisi democratica non è una crisi della democrazia rappresentativa, ma una crisi di consenso e cooperazione.
In realtà questa storia, cioè che si vive di ripiego in una democrazia rappresentativa[1] è legata all’idea che se fossimo tutti in una piccola comunità, in cui tutti si conoscono, e tutti fossero informati e ragionevoli, tutti disposti a deliberare insieme, allora si arriverebbe alla vera democrazia, dove la partecipazione è universale, continua e diretta. La storia continua suggerendo che, purtroppo, viviamo in comunità sempre più grandi e, quindi, che è necessario delegare. Non è così: in realtà la democrazia rappresentativa è anzitutto una questione di strutturazione del potere e solo successivamente una questione di regole o valori (il dibattito tra chi pensa che la democrazia sia una questione di regole e chi pensa che sia una questione di valori è antico almeno quanto la Rivoluzione Francese). Se non si coglie questo elemento fondamentale, si continua a ritenere che in realtà la democrazia rappresentativa sia un ripiego all’impossibilità di fare quella diretta.
In realtà, se si ha in mente una visione strutturale del potere, si capisce che la democrazia nasce anzitutto dalla separazione tra chi il potere ce l’ha (sovranità) e chi il potere lo esercita (governo). È in questo che risiede l’inizio di qualsiasi forma di democrazia.
Ma proprio questa separazione strutturale rende la democrazia rappresentativa la soluzione principale e preferibile, non un ripiego. Se non si capisce questo, se si è ancora dell’idea che in realtà la democrazia rappresentativa sia soltanto un ripiego, allora con il digitale questo ripiego non è più necessario, e la crisi della democrazia sembra una crisi della democrazia rappresentativa legata alle possibilità del digitale di promuovere versioni dirette. È vero, il digitale permette una democrazia diretta: ognuno di noi con una app può votare. Quindi, l’idea di Stuart Mill secondo cui non si poteva avere democrazia diretta per mancanza di mezzi oggi non funziona più. Ma quello che andava detto fin dall’inizio è che è una scelta e non un ripiego quella di separare chi il potere ce l’ha da chi lo esercita, perché se i due si uniscono (se chi ce l’ha lo esercita) allora si ha una dittatura (della maggioranza o di pochi). Le voci di chi è escluso, in questo modo, non saranno mai ascoltate.
Per riassumere, ogni vera democrazia parte da una separazione strutturale della sovranità dalla governance, per assicurare che quando la maggioranza vince la minoranza non perde.
Quando vince la maggioranza, in una democrazia, la minoranza è protetta, non viene eliminata, soffocata, silenziata. Se si pensa in modo diverso, finisce tutto a “gergo calcistico” e la politica diventa un gioco a somma zero dove ci sono solo vincitori e perdenti. In realtà, non si scende in campo, non si lotta contro qualcuno, bensì ci si unisce per ottenere tutti migliori risultati. Per questo la separazione strutturale del possesso dall’esercizio del potere è ancora più importante della separazione successiva dei tre poteri.
A questo punto la vera difficoltà emerge ed è quella relativa al fatto che quando si è separato chi il potere ce l’ha da chi lo esercita poi bisogna trovare il modo di rimettere insieme le due parti: ciò va sotto il nome di consenso. Per creare consenso bisogna affrontare un problema di complessità del coordinamento, tra chi poi il potere – avendocelo – lo vuole anche delegare. Alcuni problemi globali hanno un alto grado di complessità di coordinamento, cioè richiedono tante di quelle unità per essere risolti che a volte hanno una complessità massima: è come dire, se per far partire la macchina bisogna essere in 5 per spingerla tutti insieme, la complessità di coordinamento di questo problema sarà allora pari a 5. Siccome la globalizzazione o la giustizia sociale sono problemi molto complessi in questo senso specifico, ossia quante persone, quanti sistemi, quanti nodi della rete devono coordinarsi affinché la soluzione sia reale, arrivare a una soluzione è complicato.
Di qui la conclusione che il “Fattore C” (cooperazione, collaborazione, coordinamento) è fondamentale e si basa su meccanismi che devono essere sufficientemente robusti al fine di essere migliorato: al momento, in gran parte, ci siamo raccontati una storia sbagliata, ovvero che o è lo Stato o è il mercato a gestire i meccanismi per l’incremento del “Fattore C” che porta alla soluzione di problemi ad alta complessità che quindi creano consenso e fanno funzionare la democrazia rappresentativa.
Purtroppo, questo paradosso del coordinamento della complessità oggi è ancora più vivo di quanto non fosse ieri, perché in una società globale gli individui, da un lato, pensano di poter essere sempre più individualisti; dall’altro, proprio perché è una società affluente, i problemi che bisogna affrontare a livello di società hanno costi di coordinamento sempre più alti.
Il Terzo settore, in questo contesto, arriva come soggetto “risolutore”: tuttavia, ciò che è “buono” a livello locale non sempre lo è anche a livello globale.
Ciò che manca è creare una infrastruttura etica, un minimo di valori o meglio un minimo di capacità di coordinamento tale che, dato il livello di complessità dei problemi con cui si ha a che fare, si trovi anche il numero di nodi sufficienti affinché quella rete li risolva. È in questo frangente che il Terzo settore fa la differenza: questa infraetica è quello che facilita (o blocca, se si stratta di azioni o comportamenti negativi) in modo di volta in volta coordinato, collaborativo o cooperativo, gli agenti e le loro scelte, le azioni e le loro conseguenze, gli stati del sistema e il loro sviluppo. In questo senso, c’è bisogno di più infraetica, di più infrastruttura morale: le cose come la neutralità, la sicurezza, la privacy, la trasparenza sono elementi che facilitano la bontà del sistema.
In conclusione, la crisi democratica attuale è in parte un fallimento nella governance consensuale di quella complessità di coordinamento di cui le nostre società hanno tanto bisogno. Non si tratta solo di un problema etico, inteso come “fare bene”, bensì anche di fare in modo che il sistema nella sua complessità funzioni a favore di tutto il resto. In questo caso, allora, la nostra necessità è di avere più infraetica e, quindi, più Terzo settore che assume un’importanza fondamentale.
Il coordinamento non è emergentismo: quando ci si mette tutti insieme, non è vero che ogni elemento, svolgendo la sua parte, porta sempre ad un emergere di un coordinamento desiderato. Se il singolo esegue in autonomia la sua funzione (es. Stato o mercato) ciò può non essere sufficiente. In questo caso, bisogna avere anche progetti più ambiziosi, quindi da “società civile”, e abbassare quelli che gli economisti chiamano i “costi di opportunità” (tutte le cose non fatte che si sarebbero potute fare se soltanto ci fosse stato modo e capacità organizzativa). Non è sufficiente quindi avere un metaprogetto che sia soltanto a protezione di progetti individuali: serve, invece, un progetto sociale, cioè che metta i singoli insieme come comunità. Ciò non significa che se la società civile entra in questa dinamica qualcun altro (Stato o mercato) può tirarsene fuori, come è successo in Gran Bretagna.
Il digitale è nato per aiutarci a metterci insieme; non è nato per dividere, bensì per coordinarci, per fare in modo che si potessero affrontare sfide più complesse, ma insieme. Si può tornare a questo progetto, ma solo assumendo regole migliori.
[1] “[…] since all cannot, in a community exceeding a single small town, participate personally on any but some very minor portions of the public business, it follows that the ideal type of a perfect government must be representative.” (Stuart Mill, 1861).
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________